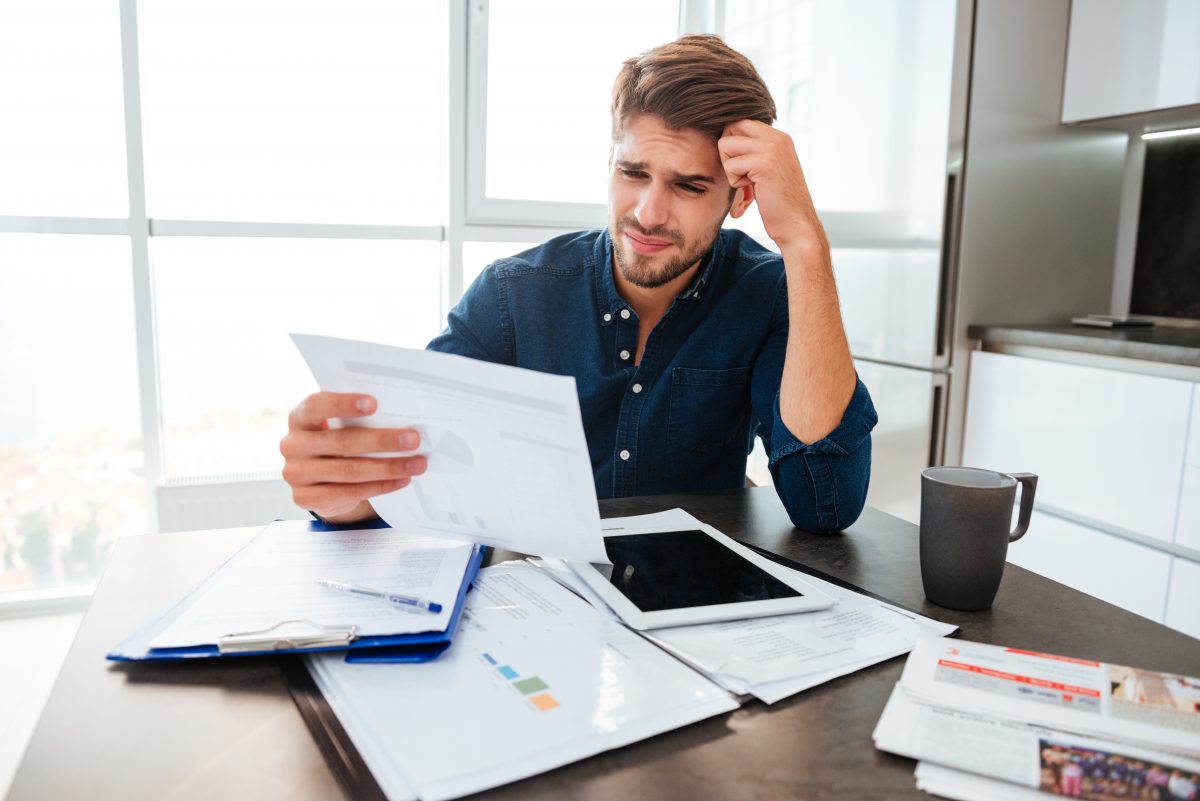L’accordo (o sarebbe meglio dire il compromesso silenziosamente contestato) sui dazi al 15% tra Unione Europea e Stati Uniti sta mettendo a nudo tutte le fragilità di un’Europa che si dice “unita” solo nei proclami, ma che nella sostanza rimane un conglomerato di interessi divergenti e sistemi economici profondamente disallineati.
Secondo Svimez, l’Italia potrebbe perdere fino a 103.000 posti di lavoro a tempo pieno a causa di questa misura, con un crollo dell’export di oltre 8,6 miliardi di euro all’anno. Numeri da shock, che non colpiscono un’Europa astratta, ma un Paese reale, già alle prese con una crescita economica stentata, disuguaglianze regionali e una pressione fiscale tra le più alte del continente.
Ed è proprio questo il punto: come può l’Unione Europea firmare accordi commerciali che incidono con violenza su una delle sue economie fondatrici, senza prima armonizzare i sistemi fiscali, produttivi e occupazionali degli Stati membri?
In che misura un Paese come l’Italia, con un’industria manifatturiera fortemente esportatrice e un Nord iper-produttivo, può essere rappresentato dagli stessi parametri che regolano economie basate principalmente sui servizi o su modelli di competitività completamente diversi?
La risposta è semplice: non può.
L’illusione di una “voce comune” in politica estera, fiscale e commerciale si frantuma ogni volta che l’Unione firma in nome di 27 Paesi che condividono una moneta ma non una fiscalità, che convivono in uno spazio Schengen ma non hanno una visione economica comune, che usano la parola “solidarietà” come copertura retorica di decisioni che beneficiano pochi e penalizzano molti.
Il caso dei dazi al 15% ne è solo l’ultimo esempio. Le regioni più colpite sono quelle con maggiore vocazione all’export industriale: il Nord Italia subirà il 68,32% della riduzione dell’export, con picchi drammatici in Valle d’Aosta (-34%) e Trentino Alto Adige (-19%). Ma anche il Mezzogiorno e il Centro Italia non sono immuni, con decine di migliaia di posti a rischio.
Che senso ha, dunque, stipulare accordi “a nome dell’Europa” quando gli effetti sono così sbilanciati da sembrare disegnati su misura per penalizzare alcuni Paesi a vantaggio di altri?
L’Europa che firma questi accordi non è unita, non è equa, non è lungimirante.
È un’istituzione tecnocratica che manca di una reale rappresentanza dei popoli, che firma trattati pensando a Bruxelles e Berlino, ignorando Torino, Taranto o Terni. E questo scollamento è ciò che alimenta disillusione, euroscetticismo e crisi di fiducia in tutto il continente.
Un’Unione che non armonizza i suoi strumenti fiscali e occupazionali, ma impone regole comuni sui mercati, è un’Unione finta.
E un accordo commerciale senza una reale convergenza economica tra i firmatari è solo un’altra forma di colonizzazione economica mascherata da progresso.
Prima di firmare a nome dell’Europa, si cominci a costruirne una vera.